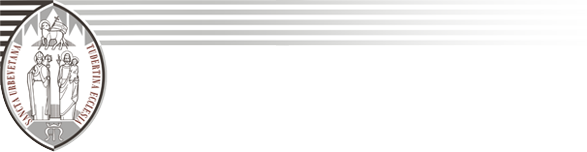Il nostro ritrovarci ha una valenza simbolica speciale, poiché il senso stesso dell’Anno Santo è quello di “fare una sosta” dalla frenesia che contraddistingue sempre più la vita quotidiana e persino quella pastorale, per rinfrancarsi e per nutrirsi di ciò che è veramente essenziale: riscoprirsi figli di Dio e in Lui fratelli, “pellegrini di speranza”.
Il Giubileo risale a un’antica tradizione giudaica, quando il suono di un corno d’ariete (yobel) ogni quarantanove anni ne annunciava uno di clemenza e liberazione per tutto il popolo (cf. Lv 25,10). Questo solenne appello doveva idealmente riecheggiare per tutto il mondo (cf. Lv 25,9), per ristabilire la giustizia di Dio in diversi ambiti della vita: nell’uso della terra, nel possesso dei beni, nella relazione con il prossimo, soprattutto nei confronti dei più poveri e di chi era caduto in disgrazia. Il suono del corno ricordava a tutto il popolo, “ricchi e poveri insieme”, di porre fine al “collasso della speranza”, condizione che lascia il posto a stati d’animo di paura, d’impotenza e di sfiducia.
L’Anno Santo, posto da Papa Francesco sotto il segno della speranza, non ci trovi “vagabondi disperati”, ma “pellegrini di speranza”, la quale “non delude” (cf. Rm 5,5) e neppure illude. Essa è una forza che viene da Dio, il quale chiama, pastori e fedeli, a diventare testimoni della “gioia del Vangelo”, la quale nasce dall’incontro con Cristo e orienta verso i fratelli, in particolare coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi, i poveri. La gioia è, dunque, inseparabile dalla speranza ed è anche indissociabile dalla missione propria dei catechisti, “il cui apostolato laicale, che arriva al fronte della Chiesa, possiede un’indiscussa valenza secolare”, cioè un forte carattere battesimale. Per i catechisti essere “pellegrini di speranza” significa non solo “camminare insieme”, ma anche avere il coraggio di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”, annunciando il Vangelo anche al di fuori delle strutture consolidate, abituali.
“Essere” e non, semplicemente, “fare” i catechisti, seguendo l’esempio di Giovanni Battista, “profeta di speranza”. Nei lineamenti del Precursore – il termine “cursore” riflette il suo etimo latino cursor, che esprime il concetto di qualcosa che corre e che ha la funzione di indicare – è possibile scorgere il profilo di un catechista affidabile, cioè consapevole che unica autorità ammessa è quella della testimonianza e unico approccio possibile è quello di camminare a fianco, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Egli stesso lo raccomanda ai discepoli nell’Ultima Cena, prima di consegnarsi volontariamente alla passione: “Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me” (Gv 15,4). Come è possibile assumere questa postura? Piegando le ginocchia “in pensosa adorazione” e tendendo l’orecchio alla Parola. Chi mette Cristo al centro della propria esistenza si apre ai fratelli; si tratta di un movimento di “sistole” e “diastole”, che Paolo traduce in questi termini: “L’amore di Cristo ci spinge” (2Cor 5,14), “ci possiede”.
Ripartire da Cristo significa non aver paura di suonare il campanello delle case, per incontrare i genitori, “primi catechisti e maestri della fede per i loro figli”. Illuminante, al riguardo, può essere la storia di Giona, un uomo pio, con una vita tranquilla e ordinata, che lo porta ad avere i suoi schemi ben chiari, ma troppo rigidi. Perciò quando il Signore lo chiama e gli dice di andare a predicare a Ninive, Giona non se la sente, fugge e si imbarca su una nave (Gio 1,1-3). La grande città pagana è al di fuori dei suoi schemi, ma Dio lo insegue, anzi, lo precede e lo rimette in cammino verso Ninive, a cui, suo malgrado, porta l’invito alla conversione (cf. Gio 3,4).
Nella “sindrome di Giona” si nasconde, oltre alla tentazione di scappare, l’insidia di non riconoscere che “le cose di Dio avanzano silenziosamente”. La smania attivistica non risponde alla parabola del granello di senape (cf. Mc 4,31-32), da leggere in sinossi con la metafora del chicco di grano caduto in terra (cf. Gv 12,24). Ogni catechista deve lasciarsi ammaestrare dalla logica del grano di senape, come pure da quella del grano di sale, perché la fecondità apostolica non dipende “dall’eccellenza della parola o della sapienza”. Egli non ha altre credenziali che quelle con cui Paolo si è accreditato presso la comunità di Corinto confessando di “non sapere altro se non Cristo crocifisso” (cf. 1Cor 2,2): “Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza” (1Cor 2,3-4).
Ritenendo di “non sapere altro se non Cristo crocifisso” (cf. 1Cor 2,2), un catechista non può rinunciare allo studio e alla riflessione, allo scopo di avere ben presenti i contenuti essenziali dell’evangelizzazione, come, ad esempio, l’inscindibilità dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il contenuto fondamentale del Primo Testamento è riassunto nel messaggio di Giovanni Battista: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino!” (Mt 3,2). Non c’è accesso a Gesù senza rispondere all’appello del Precursore a rinnovare la mente e il cuore, bonificando lo sguardo. Gesù stesso ha assunto il messaggio di Giovanni nella sintesi della sua predicazione: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15). La parola greca “metanoia”, che indica il cammino di conversione, significa: ripensare, anzi, mettere in questione il proprio modo di vivere; lasciar entrare Dio come misura e criterio della propria vita.
Nella chiamata alla conversione è implicito – come sua condizione fondamentale – l’annuncio del Regno di Dio con parole e immagini, ma prima di tutto con l’eloquente silenzio della propria vita di preghiera. La fede si trasmette non per contagio, ma per attrazione, da persona a persona. Quando i primi discepoli si avvicinano a Gesù chiedendogli “Maestro, dove dimori?” (Gv 1,38), Egli non risponde dando loro l’indirizzo di casa, ma dicendo: “Venite e vedrete” (v. 39). “Solo nell’esperienza della vita con Dio appare anche l’evidenza della sua esistenza”. Parlare di Dio e parlare con Dio devono sempre andare insieme: sono, per così dire, il biglietto da visita della comunione con Lui, fondata e vivificata nella vita sacramentale.
Un altro elemento centrale di ogni vera evangelizzazione è l’annuncio della vita eterna, un aspetto spesso trascurato della predicazione di Gesù. L’articolo di fede del “giudizio” è un contenuto fondamentale del Vangelo delle beatitudini (cf. Mt 5,1-11). Senza prendere sul serio la serietà della responsabilità della propria libertà è impossibile comprendere la redenzione, cioè il fatto che Dio stesso nella passione del Figlio suo si fa “avvocato” dell’uomo peccatore. Solo credendo al giusto giudizio di Dio, solo avendo fame e sete della giustizia è possibile aprire il cuore alla misericordia divina. Solo se la misura della vita è l’eternità, anche la esistenza terrena ha il suo valore immenso. “Dio non è il concorrente della nostra vita, ma il garante della nostra grandezza”; Egli è il custode della nostra libertà, “segno altissimo dell’immagine divina”.
Rendere testimonianza di una vita autenticamente cristiana: questo è “il primo mezzo di evangelizzazione”. Lo scrive Paolo VI nell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, osservando che “l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. Quanto sia necessario narrare la gioia del Vangelo, in tutta la chiarezza della sua bellezza, Papa Montini lo sottolinea con forza, replicando a questa acuta osservazione di Jean Guitton, filosofo francese, esponente del pensiero cattolico: “Ci sembra che la Chiesa dubiti di possedere l’Assoluto, che essa sia preoccupata più della vita che della verità, che voglia adattarsi al mondo, parlare il linguaggio del mondo, che abbia paura della solitudine che viene dal possesso della verità, quella verità che molti uomini d’oggi rifiutano, che vada nel senso della storia mutevole”. Paolo VI risponde: “Non si deve separare ciò che si deve distinguere. Carità e verità non si troveranno mai in contrasto nella dottrina della Chiesa perché, quando la carità è spinta all’estremo, alla sua dimensione sublime, diviene carità-amore della verità. Il Concilio si preoccupa di rendere questa verità più accessibile, più assimilabile agli uomini di questo tempo, così facendola anche più vera, perché quanto più è amata più la verità si rivela efficace”. A queste osservazioni Papa Montini aggiunge: “L’ordine del cristianesimo non è statico. È un ordine di sviluppo, una promozione al meglio, un equilibrio nel movimento. Il cristianesimo ha il genio della riforma e del nuovo, ma anche quello della tradizione della fedeltà. È per natura insoddisfatto”.
Commentando questa riflessione di Paolo VI, il card. Matteo Zuppi ha confidato, ai membri del Consiglio permanente della CEI, un suo desiderio per la Chiesa in Italia, che faccio mio per la Diocesi di Orvieto-Todi: “Mi piacerebbe che l’Anno giubilare costituisse il tempo in cui riflettiamo e maturiamo insieme non la volontà di essere una minoranza triste, ma il coraggio di diventare minori felici, nel senso in cui la spiritualità francescana ci ha spiegato questa idea (…). Penso a una Chiesa che sia con gioia minore come minore è stato Giovanni Battista, che dava testimonianza di un Altro più grande di lui e diceva di voler diminuire perché Lui crescesse (cf. Gv 3,26-36)”.
+ Gualtiero Sigismondi