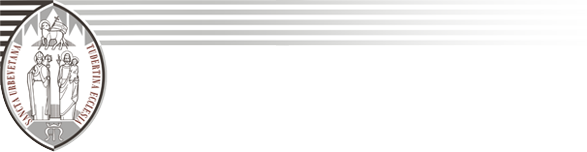Dopo l’Annunciazione del Signore, Maria si alza e si mette in viaggio, “in fretta” (cf. Lc 1,39), come “pellegrina di speranza”. Avverte la spinta dell’amore che la conduce ad aiutare Elisabetta la quale accoglie, dopo lunga attesa, una gravidanza insperata, faticosa da affrontare alla sua età. La Vergine condivide con sua cugina la fede in Dio, “a cui nulla è impossibile” (cf. Lc 1,37). L’incontro tra le due donne produce un impatto sorprendente: la voce della “piena di grazia” fa sussultare il bambino che l’anziana porta in grembo (cf. Lc 1,41) e lo Spirito santo, di cui è colma, le ispira una duplice benedizione (cf. Lc 1,42) e una beatitudine (cf. Lc 1,45).
Maria, “discepola della Parola”, innalza un inno di lode, il Magnificat (Lc 1,46-55); Ella scrive le “note” del suo Cantico su un “pentagramma” intessuto di risonanze bibliche, come, ad esempio, il Siracide, ove si legge che “principio della superbia è allontanarsi dal Signore”, il quale “ha rovesciato i troni dei potenti e al loro posto ha fatto sedere i miti, ha estirpato le radici delle nazioni e al loro posto ha piantato gli umili” (Sir 10,12-18). Maria canta il Magnificat in polifonia, con la tecnica compositiva del contrappunto, che sovrappone più linee melodiche.
Nel Magnificat, solenne memoriale che celebra il mistero di Dio nella storia, i verbi sono tutti al passato, impregnati di una memoria d’amore che accende di fede il presente e illumina di speranza il futuro. La storia non si esaurisce nel presente, né si consuma nel passato, ma si snoda verso il futuro. “Maria canta la grazia del passato – osservava Papa Francesco – ma è la donna del presente che porta in grembo il futuro. La prima parte di questo Cantico loda l’azione di Dio in Maria, microcosmo del popolo di Dio che aderisce pienamente all’alleanza (cf. Lc 1,46-50); la seconda spazia sull’opera di salvezza del Padre nel macrocosmo della storia (cf. Lc 1,51-55)”.
Come Dio ha innalzato la Vergine Maria alla sublime dignità di Madre, così l’ha coronata di gloria incomparabile, quale “primizia della redenzione”. Una lunga consuetudine iconografica presenta l’Assunta circondata dagli apostoli, come a Pentecoste. La tribuna della nostra Cattedrale mostra i Dodici stretti attorno al capezzale della Vergine. La loro postura esprime venerazione, il loro sguardo mostra i riflessi del pianto e dell’incanto i quali, per così dire, sono la sistole e la diastole dei loro cuori, il cui battito fa sentire l’accordo dei sentimenti dell’anima.
Fratelli e sorelle carissimi, lodiamo il Signore “con la vita e con la lingua, con la gioia nel cuore e il canto sulle labbra”, evitando le stonature, avverte Papa Leone XIV citando Sant’Agostino (cf. Discorso 256,1). La voce intonata con la vita: con questo accordo non trascuriamo di recitare il Rosario, “preghiera dalla fisionomia mariana e dal cuore cristologico, che concentrando in sé – diceva Giovanni Paolo II – la profondità dell’intero messaggio evangelico”, insegna – precisava Papa Francesco – “a tenere il cuore fisso su Gesù, con lo sguardo contemplativo di Maria”.
+ Gualtiero Sigismondi